Se il passato diviene idea d’impresa e la possibilità di costruire nuovi racconti.
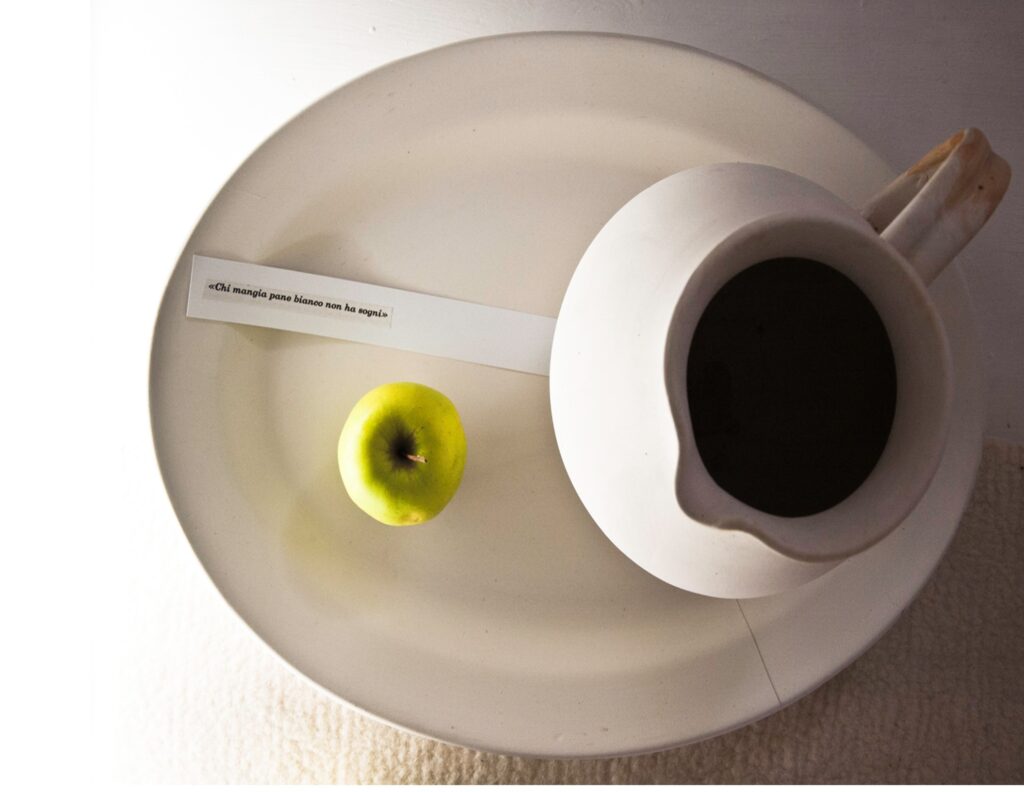
L’intento è dare visione a una nuova modernità. Negli ultimi anni, opposte concezioni di modernità e le maggiori conoscenze emerse dagli studi post-coloniali hanno permesso di giungere alla definizione di “pluri-modernità”. Viviamo in un momento tumultuoso. Mai prima d’ora le arti applicate sono state così importanti, ma raramente il loro ruolo è stato tanto difficile. È chiaro che stiamo attraversando un periodo di grande transizione, per quanto riguarda le relazioni globali, poiché siamo sempre più coscienti che il nostro pianeta non può continuare ad usare le forme di pensiero sociale, economico e politico che lo hanno dominato nei due secoli passati. Nel complesso tutti questi cambiamenti vengono identificati con la modernità, un fenomeno che oggi agisce su tutto il pianeta. Sono così tanti gli studiosi e i critici delle più svariate discipline ad aver dato definizioni (spesso contraddittorie) della modernità, che “il moderno” è diventato un’industria accademica di un certo rilievo. Forse è il caso di esaminare brevemente il passato per comprendere le ragioni del cambiamento e per fare qualche ragionevole previsione di miglioramento.
Lo sviluppo di tecnologie o di prodotti era per lo più un fatto aziendale, al più il sistema delle imprese cercava fuori “artigiani” di alta qualificazione da poter utilizzare come consulenti nei casi difficili, come un aiuto nei rapporti internazionali. Negli ultimi anni, il quadro è cambiato sia per la profonda trasformazione verificatasi nel sistema economico, sia per le profonde trasformazioni nei processi formativi e produttivi. La grande impresa si è estinta e sono nate piccole e medie imprese che hanno sempre maggiori difficoltà nel mantenere in vita e aggiornare le loro strutture di ricerca. Invocano una migliore formazione e una maggiore selezione per i futuri professionisti e dirigenti, desiderano una cultura più mirata e più rapidamente spendibile sul lavoro per coloro che sono destinati a mansioni più esecutive.

L’artigiano pur nella «genericità» della definizione data da Sennett (nel suo libro, “L’uomo artigiano”), sa guardare quel mondo con un occhio diverso, rispetto a quello – voracissimo – degli squali della finanza, alta o bassa che sia. Sa guardare il mondo, suggerisce ancora lo studioso statunitense, riuscendo a cogliere le conseguenze di ogni suo gesto. Diversamente, gli apprendisti stregoni del capitale «flessibile» hanno perso ogni capacità di controllare l’operato del proprio lavoro, di testarlo, di sottoporlo a prova, di vagliarne al massimo grado di prevedibilità le conseguenze. L’applicazione del design nel nostro Paese ha seguito un modello peculiare, secondo un processo generativo e riproduttivo largamente spontaneo, frutto dell’alleanza tra piccole e medie imprese inserite in territori produttivi d’eccellenza ed architetti, intellettuali e creativi, che ha rappresentato il punto di forza di una particolare produzione italiana e al tempo stesso ha contribuito a relegare il design all’interno di una nicchia concettuale non consentendo la piena diffusione delle sue potenzialità.
L’amore moderno per il lavoro è l’amore di ciò che si può ottenere con il lavoro, e non è in contraddizione con chi non vede l’ora che la giornata sia finita. Invece l’amore per il lavoro dell’uomo preindustriale è l’amore per il proprio mestiere nella sua integrità, materiale, intellettuale e spirituale. È l’amore per quello che il lavoratore sta facendo in quel dato momento, è la passione di fare bene una cosa, di vederla realizzata “a regola d’arte”, come si soleva dire una volta. Infatti, il preconcetto di considerare le arti applicate come appartenenti ad un “area inferiore”, ha dominato in parte tutta la storia del movimento moderno ed alcune scuole di pensiero, che credevano di poter pronosticare la fine di ogni manualità in nome di una meccanizzazione sfrenata.
Un progetto intriso di memoria passa per questa strada, con lo sviluppo di attività di laboratorio flessibili aperte al mondo del fare artigianale: progettare il dialogo e lo scambio. La storia del Lanificio Leo dimostra che è possibile realizzare occupazione e sviluppo recuperando un antico stabilimento dismesso in un lungo apparentemente lontano dai grandi circuiti internazionali. E invece ci sono storie che raccontano l’opposto: sognare un futuro nel luogo dove si è nati e cresciuti puntando su idee nuove non è solo ipotizzabile, ma può essere realtà. Il Lanificio Leo a Soveria Mannelli e la storia di Emilio Leo – figlio di una caparbia idea di riprendere l’azienda considerata dai più nel migliore dei casi “un reliquato” – ne sono una prova tangibile. Un luogo che ha ospitato per tantissimi decenni migliaia e migliaia di storie personali». Emilio Leo lo definisce una sorta di «frantoio della lana».
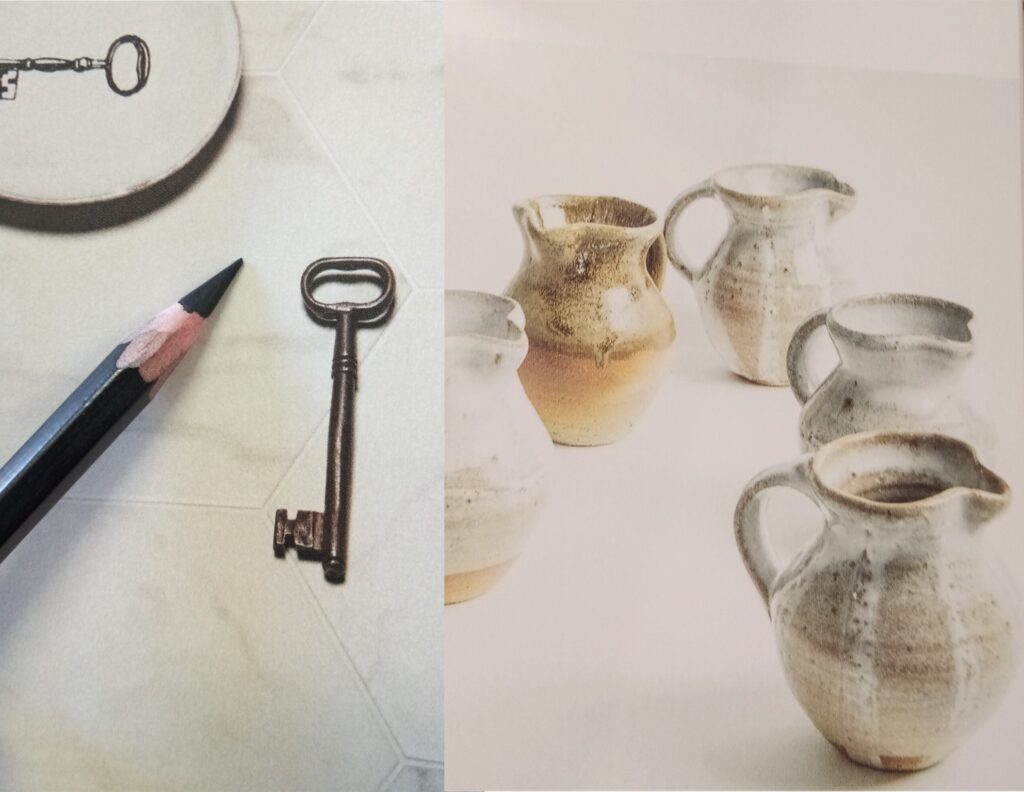
«Cioè un luogo in cui le persone venivano con le proprie piccole quantità di lana merinos – afferma – e la facevano trasformare in filo, in tessuto, o la scambiavano sul posto con la produzione di tessuti». Soltanto da un rigoroso processo, in grado di integrare virtuosamente tutti questi aspetti, può nascere un intervento capace di garantire, nel tempo, qualità.
Creatività significa capacità di produrre nuove idee, e lo stesso dizionario conferma che l’atto creativo è preliminare all’atto di innovare (cioè di trasformare introducendo sistemi o metodi nuovi, De Mauro). Comunque, sembra che vi siano gli spazi per un nuovo modo di intendere la capacità artigianale, intesa come precisa volontà di ritrovare l’autenticità minacciata da ogni parte, che “…….è la quintessenza di tutto ciò che, fin dall’origine di essa può venire tramandato dalla sua durata materiale alla sua virtù di testimonianza storica…” (“L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” Walter Benjamin, anno 1966).




